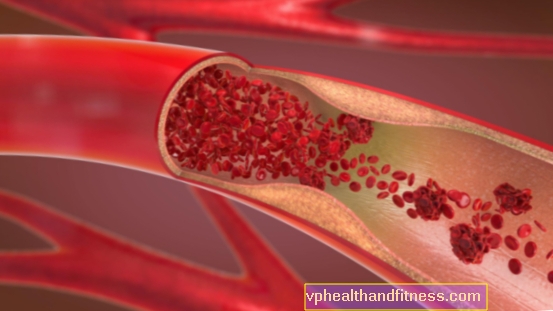L'osteosarcoma (osteosarcoma latino) è un tumore maligno che ha origine nel tessuto osseo. Scopri chi sviluppa più spesso l'osteosarcoma, quali sono i sintomi dell'osteosarcoma, quali test diagnostici dovrebbero essere eseguiti quando si sospetta l'osteosarcoma e come viene trattato l'osteosarcoma.
Sommario:
- Osteosarcoma - introduzione. Struttura ossea
- Osteosarcoma - fattori di rischio
- Osteosarcoma - sintomi
- Osteosarcoma - diagnosi
- Osteosarcoma - classificazione. Livelli di progresso
- Osteosarcoma - trattamento
- Osteosarcoma - prognosi
Osteosarcoma (osteosarcoma, latino. osteosarcoma) è più spesso diagnosticato nei giovani, specialmente nel periodo di crescita intensiva.
Sebbene l'incidenza dell'osteosarcoma sia relativamente bassa (nella popolazione polacca si tratta di circa 80 nuovi casi all'anno), questo gruppo di tumori non deve essere sottovalutato.
In caso di problemi all'apparato scheletrico inspiegabili, va sempre escluso un possibile processo neoplastico.
Il trattamento degli osteosarcomi è generalmente aggressivo e multidirezionale e una diagnosi precoce aumenta le possibilità di successo della terapia.
Osteosarcoma - introduzione. Struttura ossea
Prima di descrivere gli osteosarcomi, diamo una breve occhiata agli organi in cui si sviluppano questi tumori: le ossa.
A causa della forma, ci sono diversi tipi di ossa:
- ossa lunghe
- ossa corte
- ossa piatte
- ossa di varia forma
Sentendo il nome "osso" la maggior parte di noi probabilmente immagina un osso lungo. Esempi di ossa lunghe nel nostro corpo includono
- omero
- femore
- osso tibiale
- ulna
Quando parliamo di osteosarcomi, ci concentreremo principalmente su questo gruppo di ossa.
Si stima che fino all'80-90% degli osteosarcomi si sviluppi nelle ossa lunghe.
Ci sono 3 strutture di base nella costruzione dell'osso lungo: l'epifisi prossimale, l'asta e l'epifisi distale. Le radici delle ossa lunghe sono ricoperte di cartilagine e formano superfici articolari.
Tra l'albero e la base delle ossa ci sono i cosiddetti scantinati.
Un altro elemento molto importante si trova all'interno delle metafisi: la cartilagine di crescita. La cartilagine di crescita consente all'osso di crescere longitudinalmente. Quando il processo di crescita è completo, questa cartilagine si trasforma in osso.
Le epifisi delle ossa lunghe sono il sito in cui si sviluppano più spesso gli osteosarcomi.
Tra queste, si dovrebbero distinguere l'epifisi distale del femore e l'epifisi prossimale della tibia, cioè strutture situate nelle immediate vicinanze dell'articolazione del ginocchio.
Si stima che fino alla metà degli osteosarcomi si trovi nell'area del ginocchio.
Un altro luogo relativamente comune per questi tumori è l'omero. Gli osteosarcomi localizzati nello scheletro assiale (cranio, colonna vertebrale, bacino) o nelle piccole ossa delle mani e dei piedi sono molto meno comuni.
Osteosarcoma - fattori di rischio
Esistono diverse ipotesi sulle cause dell'osteosarcoma. I fattori specifici alla base dello sviluppo di questi tumori sono ancora sconosciuti.
In molti pazienti, la formazione di osteosarcomi sembra essere associata al cosiddetto salto di crescita, cioè rapida crescita ossea in lunghezza. Questa relazione è sia temporanea (picco di incidenza nella seconda decade di vita) sia localizzata (osteosarcomi che si sviluppano in prossimità delle cartilagini di crescita).
Leggi anche: Dolori della crescita, cioè dolori muscolari nei bambini legati alla crescita dell'organismo
Il sesso è un fattore di rischio indipendente: gli osteosarcomi sono più comuni negli uomini (frequenza 3: 2 rispetto alle donne).
Nei pazienti più anziani, gli osteosarcomi possono svilupparsi sulla base di una malattia ossea preesistente. Sto parlando principalmente di vari tipi di displasie ossee, cioè malattie legate alla struttura anormale del tessuto osseo.
Un altro fattore di rischio sono le radiazioni ionizzanti: le ossa precedentemente irradiate sono a maggior rischio di processi neoplastici. Questo rischio aumenta con la dose di radiazioni assorbite.
Raccomandiamo: Malattia da radiazioni - sintomi, trattamento ed effetti
È anche noto che la predisposizione genetica gioca un ruolo nella formazione degli osteosarcomi. Finora sono noti diversi geni, le cui mutazioni possono contribuire ad un aumento del rischio di sviluppare l'osteosarcoma.
Osteosarcoma - sintomi
I fattori di rischio per lo sviluppo di osteosarcomi menzionati nella sezione precedente mostrano quanto poco sappiamo sulla formazione di queste neoplasie. Di conseguenza, ci sono anche poche possibilità di profilassi dell'osteosarcoma. Per questo motivo, è molto importante seguire le regole del cosiddetto vigilanza oncologica.
Vale la pena sapere quali sintomi può dare l'osteosarcoma e quando è assolutamente necessario approfondire la diagnosi di questo tumore.
- Dolore alle ossa
Il primo e più comune sintomo dell'osteosarcoma è il dolore osseo. I disturbi sono solitamente localizzati in un luogo specifico. Un sintomo particolarmente fastidioso (chiamato "bandiera rossa" in oncologia) è il dolore che si manifesta di notte e sveglia il paziente dal sonno.
- Gonfiore dei tessuti molli adiacenti
Un altro sintomo comune è il gonfiore dei tessuti molli adiacenti. In caso di avanzamento significativo del tumore, accade che il tumore sia visibile ad occhio nudo.
A differenza di molte altre neoplasie, gli osteosarcomi raramente causano sintomi generali come
- anemia
- febbre bassa
- perdita di peso
- debolezza
Un dolore osseo improvviso e grave può derivare da una frattura patologica come conseguenza dell'indebolimento della struttura ossea da parte del cancro che si sviluppa in essa.
Osteosarcoma - diagnosi
Il primo stadio nella diagnosi di osteosarcoma è una storia medica e un esame fisico.
Per visualizzare eventuali cambiamenti nelle ossa, è necessario eseguire test di imaging.
Il tipo base di imaging è la radiografia. L'immagine a raggi X negli osteosarcomi è eterogenea: l'immagine può mostrare sia i punti di distruzione del tessuto osseo sia il suo accumulo.
Un sintomo caratteristico sui raggi X degli osteosarcomi è il cosiddetto Triangolo di Codman, cioè elevazione del periostio in prossimità dell'infiltrazione del tumore.
L'immagine a raggi X consente di visualizzare la patologia, sebbene la valutazione accurata della sua estensione e del grado di avanzamento richieda ulteriori ricerche.
La risonanza magnetica viene eseguita per visualizzare meglio l'interno delle ossa (cavità mieloidi), nonché i tessuti molli circostanti.
La fase successiva della diagnostica è rilevare possibili focolai metastatici.
L'osteosarcoma è una neoplasia maligna che può metastatizzare attraverso il flusso sanguigno.
Si stima che alla diagnosi, circa il 15% dei pazienti abbia metastasi visibili nei test di imaging.
L'osteosarcoma ha la tendenza a metastatizzare all'interno dei polmoni, pertanto devono essere eseguite anche radiografie del torace o scansioni TC.
Inoltre, la diagnosi di osteosarcoma è un'indicazione per l'esame scintigrafico dell'intero scheletro. La scintigrafia consente di visualizzare focolai tumorali situati in altre ossa.
Sebbene i test di imaging spesso sospettino la malignità della lesione, la diagnosi finale è possibile solo dopo la verifica istopatologica. Per eseguire un esame istopatologico è necessario prelevare un campione del tessuto affetto dalla malattia.
Tale sezione si ottiene durante una biopsia ossea. Il patologo sottopone il materiale ottenuto a un trattamento speciale e quindi lo esamina al microscopio. Il risultato dell'esame istopatologico consente di stabilire la diagnosi e classificare la neoplasia in base al tipo e al grado di avanzamento.
Osteosarcoma - classificazione. Livelli di progresso
Gli osteosarcomi possono essere classificati in base a vari criteri. Il primo tipo di valutazione è il grado del tumore, chiamato grading.
La classificazione risponde alla domanda su quanto gravi siano le caratteristiche di malignità nelle cellule del tumore in esame.
La scala di valutazione per l'osteosarcoma è di quattro gradi (da G1 a G4), con G1 di basso grado, G2 medio e G3 e G4 alto. Esempi di osteosarcomi appartenenti a ciascun gruppo sono:
- G1 - osteosarcoma
- G2 - extraosarcoma
- G3 e G4 - classico, angiosarcoma, osteosarcoma a piccole cellule
La seconda componente importante della valutazione degli osteosarcomi è lo stadio clinico, il cosiddetto messa in scena.
Come nel caso di molte altre neoplasie maligne, la classificazione TNM viene utilizzata per valutare lo stadio clinico, sulla base di tre caratteristiche fondamentali del tumore: la dimensione del tumore primario (T - tumore), la presenza di metastasi nei linfonodi locali (N - nodi) e la presenza di metastasi a distanza ( M - metastasi).
La stadiazione degli osteosarcomi è rappresentata dai seguenti simboli:
I. Caratteristica T (dimensione del tumore):
- T0 - nessun obiettivo primario
- T1 - lesione primaria maggiore o uguale a 8 cm (nella dimensione massima)
- T2 - lesione primaria maggiore di 8 cm (nella dimensione massima)
- T3 - altre lesioni tumorali all'interno dello stesso osso
II. Caratteristica N (linfonodi circostanti):
- N0 - nessuna metastasi nei linfonodi circostanti
- N1 - metastasi presenti nei linfonodi circostanti
III. Caratteristica M (metastasi a distanza):
- M0 - nessuna metastasi a distanza
- M1 - metastasi a distanza presenti
Osteosarcoma - trattamento
Il trattamento dell'osteosarcoma è combinato: sono importanti sia la chirurgia di rimozione del tumore che il trattamento farmacologico aggiuntivo (chemioterapia).
La radioterapia nel trattamento di questo gruppo di neoplasie mostra poca efficacia.
La fase fondamentale nel trattamento degli osteosarcomi è la chirurgia, che consiste nella completa rimozione del tumore con un adeguato margine di tessuto sano.
In passato, la diagnosi di osteosarcoma richiedeva spesso l'amputazione degli arti. Oggigiorno, grazie ai progressi nelle tecniche di chirurgia ricostruttiva, è solitamente possibile eseguire procedure meno radicali che salvano l'arto.
Consigliamo: protesi di arto inferiore e superiore
Il regime di trattamento per l'osteosarcoma comprende anche due fasi della chemioterapia: chemioterapia neoadiuvante e chemioterapia adiuvante.
- Chemioterapia neoadiuvante
La chemioterapia neoadiuvante viene somministrata prima dell'intervento chirurgico e consente di ridurre le dimensioni del tumore, facilitando così la sua escissione. Una buona risposta alla chemioterapia preoperatoria è anche un fattore prognostico favorevole.
- Chemioterapia adiuvante
La chemioterapia adiuvante viene somministrata dopo l'intervento di resezione del tumore. Lo scopo principale del suo utilizzo è distruggere il cosiddetto micrometastasi, che sono cellule tumorali residue che rimangono nel corpo nonostante la rimozione della massa tumorale principale.
Diversi farmaci vengono solitamente utilizzati in combinazione nella chemioterapia per l'osteosarcoma. I più comunemente usati sono:
- doxorubicina
- cisplatino
- ifosfamide
- etoposide
- metotrexato
La terapia multi-farmaco comporta un alto rischio di effetti collaterali, pertanto i pazienti sottoposti a chemioterapia devono essere costantemente monitorati in termini di funzioni degli organi interni (fegato, reni, cuore), nonché di complicanze infettive causate da una ridotta produzione di cellule del sangue da parte del midollo osseo.
Osteosarcoma - prognosi
La prognosi dell'osteosarcoma dipende da molti fattori, tuttavia, lo stadio del cancro alla diagnosi è di grande importanza.
Se la malattia può essere rilevata in uno stadio limitato, prima dell'inizio delle metastasi ai linfonodi o agli organi distanti, la prognosi è molto migliore.
Il regime terapeutico attualmente utilizzato:
- chemioterapia preoperatoria
- operazione chirurgica
- chemioterapia postoperatoria
consente un tasso di sopravvivenza a 5 anni nel range del 60-70%.
La prognosi peggiore riguarda l'osteosarcoma nella fase metastatica, così come i casi di recidiva di questo tumore.
Bibliografia:
- "Osteosarcoma" J. Ritter, S. S. Bielack, Annals of Oncology, Volume 21, Issue suppl_7, ottobre 2010
- "Osteosarcoma" Picci, P. Orphanet J Rare Dis (2007) 2: 6. https://doi.org/10.1186/1750-1172-2-6
- "Raccomandazioni per la gestione diagnostica e terapeutica nei pazienti con tumori ossei maligni primari negli adulti" P. Rutowski et.al. Journal of Oncology 2011, volume 61 n. 2, 159-168
--objawy-diagnostyka-leczenie_1.jpg)
Leggi altri articoli di questo autore
--objawy-diagnostyka-leczenie.jpg)